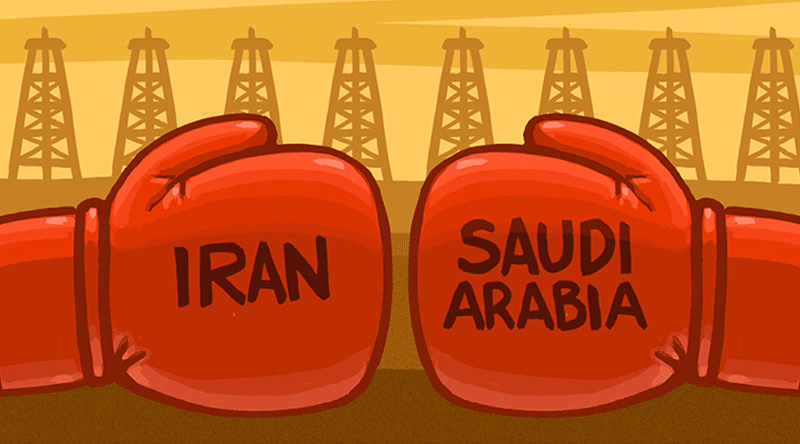L’accordo con l’Iran sul nucleare procede, confermava – nel mese di aprile – una lettera al Congresso del segretario di Stato americano Rex Tillerson. Le pressioni di Russia, Cina ed Europa, e l’innegabile adempimento agli obblighi assunti, hanno disinnescato le minacce di Trump di farlo saltare, ma non l’intenzione di diminuire l’influenza del Paese.
Il summit di Riyadh di maggio ha rinsaldato la coalizione contro il terrorismo degli Stati Uniti con l’Arabia Saudita, suo partner privilegiato dal 1945, che in verità ha l’Iran nel mirino. E a novembre sono arrivati prima la legittimazione del blitz anti-corruzione del Re Salman, per mano del principe ereditario Mohammad bin Salman – operazione classica di accentramento che liquida un pretendente al trono, dopo un’eclatante estromissione dello scorso giugno, e poi l’invito a effettuare l’offerta pubblica iniziale della Saudi Aramco sulla borsa di New York. La posteriore benedizione dell’intesa in funzione anti-iraniana fra sauditi e israeliani, delusi dall’andamento della guerra in Siria, chiude il cerchio.
Washington ha sempre auspicato un ruolo più ragguardevole per l’Arabia Saudita in Medio Oriente. Una lunga fila di presidenti l’ha indotta al confronto con protagonisti considerati radicali, secondo i propri interessi nazionali, come Gamal Addel Nasser in Egitto negli anni Sessanta. L’Iran, dal canto suo, ha occupato con assertività i vuoti di potere in Libano, Iraq e Siria. Il conflitto saudita-iraniano è di natura squisitamente geo-politica.
Diffuso come diffuse sono le rispettive aree di egemonia, è un potente catalizzatore di alleanze tattiche e mutevoli equilibri. La coalizione anti-terrorismo non è che una manovra per contenere e arretrare l’onda espansiva dell’Iran, anche a seguito del suo pieno rientro nel mercato del petrolio con il sollevamento delle sanzioni americane.
Tra fasi alterne di aperta contesa e apparente distensione, questa rivalità si è misurata intorno a eventi di portata storica, dove attori decisivi hanno migrato da uno schieramento all’altro per ragioni congiunturali. Nel 1979, in Iran, viene rovesciato il regime di Muhammad Reza Pahlavi, sostenuto dall’Occidente, e si instaura una repubblica teocratica. Nel decennio successivo, sulla spinta della rivoluzione, Teheran patrocina in maniera attiva e mirata un numero di movimenti e fazioni armate in zone strategiche della regione, rafforzando la propria posizione. In risposta, Riyadh appoggia Saddam Hussein, in guerra contro l’Iran dal 1980 al 1988, e crea il Consiglio di Cooperazione del Golfo con scopo difensivo. La caduta del dittatore, con l’invasione statunitense del 2003, e il collasso dello Stato, apre invece la strada al primato di Teheran nella politica interna irachena, grazie alla presenza di gruppi filo-iraniani.
Allo stesso modo, il torchio saudita, al limite del golpe, sul premier libanese Saad Hariri – a capo di un Governo di unità nazionale raggiunto dopo due anni di stallo, con il proposito di circoscrivere il peso di Hezbollah, partito dagli antichi e solidi vincoli con Teheran, affondano le loro radici nell’assassinio del primo ministro filo-saudita, Rafiq Hariri, nel 2005, di cui vennero accusate le milizie di Hezbollah, con la complicità della Siria, amica dell’Iran. Ciò ha determinato il ritiro delle truppe siriane dal Libano e la sospensione della pax siriana, avversa a Israele. Le primavere arabe del 2011 hanno, infine, costituito un nuovo terreno di gioco. L’Arabia Saudita, e altri con velleità geo-politiche come il Qatar, hanno cercato di sostituirsi ai processi rivoluzionari e ostacolare la proliferazione di formazioni affini all’Iran, foraggiando estremisti di matrice islamica.
Se in Egitto e Bahrain, la monarchia è riuscita a imporsi, in Yemen si è prodotta un’emergenza umanitaria che ha catturato l’attenzione internazionale, e in Iraq i risultati rimangono negativi. L’inedita ricerca di un dialogo con il primo ministro iracheno Abadi, e leader ostili a Ryhad, sulla base del concetto etnicista di “arabicità”, così come l’aut aut imposto al Qatar di scegliere fra i legami, con Iran, Turchia e Fratellanza Musulmana, e il Golfo, sono ingegnosi stratagemmi per contrastare la supremazia de facto dell’Iran.
In Siria, inoltre, l’asse Damasco-Teheran-Mosca gli ha impedito di abbattere Bashar al-Assad, confederato dell’Iran e gli esiti del conflitto, ancora in discussione, hanno messo in allarme Israele. Siria, Iran e Libano meridionale costituiscono uno schieramento di resistenza al fronte arabo-statunitense. In particolare, la Siria è l’avanguardia della politica anti-israeliana nel vicino oriente, avendo Egitto e Giordania normalizzato i rapporti con lo Stato ebraico.
L’obiettivo di lungo raggio del ritiro dal Medio Oriente è stato diversamente gestito dalle amministrazioni Obama e Trump. Dopo l’apertura all’Iran, con l’idea di porre le basi per un apparato di sicurezza condiviso, e anni di relazioni tese con Arabia Saudita e Israele, gli Stati Uniti si sono riavvicinati ai propri alleati tradizionali. La ripresa delle ostilità nei riguardi dell’Iran, tuttavia, ne ha solo acuito l’interventismo in Iraq e Yemen. E la morsa dell’Arabia Saudita sul Libano non è destinata ad avere ripercussioni positive a livello regionale.
Hezbollah, mediante l’assistenza economica e militare dell’Iran, si è trasformato in un potere autonomo rispetto al Governo libanese, incidendo su difesa nazionale e politica estera. Efficace deterrente all’avanzata di Israele sui suoi confini e la propagazione dell’Isis in Siria, è stato, ed è strumentale nelle guerre in Bahrain, Iraq e Yemen, dove Arabia Saudita e Iran si sfidano. Non è comunque intoccabile e, di fatto, la sua posizione dominante è frutto della debolezza e la divisione degli nemici locali e dell’arte della sopravvivenza.
Taglieggiare il premier eletto democraticamente – all’indomani di un vertice con il consigliere iraniano per gli affari esteri, generare una crisi interna, e usare il Libano alla stregua di un campo di battaglia, riecheggia altri fallimenti – l’ultimo del 2006, di Israele e Stati Uniti, che hanno condotto a uno sfinimento progressivo del Paese. Hezbollah può essere neutralizzato solo da un continuo impegno nella costruzione di uno stato di diritto e un tessuto democratico dove possa prosperare una diversità di espressioni politiche non pilotate dall’esterno.
Eppure il pericolo in agguato, per le elezioni parlamentari del 2018, è proprio quello delle ingerenze saudite in ausilio ai partiti loro affiliati. Riyadh reclama la revisione della nuova legge elettorale proporzionale, noncurante della sua importanza per la stabilità, per evitare di avvantaggiare Hezbollah. Riyadh potrebbe poi mettere alle strette il Libano ritirando capitali dalle banche e ponendone a rischio l’equilibrio finanziario.
Nell’immediato, il Governo che legittima l’operato di Hezbollah è infiacchito, sul medio periodo, però, con tanta incertezza prevale un pericolo più alto di qualsiasi possibile guadagno, ovvero il crollo istituzionale. L’umiliazione subita ha scontentato persino gli entourage libanesi vicini a Riyadh, spaventati da sanzioni economiche indiscriminate. Per quanto frammentato, il Libano, con il suo sistema partitico, e l’apertura religiosa, è forse l’unico modello esistente contro la radicalizzazione del Medio Oriente. E del resto, le recenti scelte saudite, si pensi alla campagna in Yemen iniziata nel 2015, non sono state brillanti e vanno ricordati anche i costi pagati in passato. L’ingerenza nella guerra civile yemenita, negli anni Sessanta, si tradusse in una completa disfatta, e all’Arabia Saudita converrebbe piuttosto ritirarsi da un conflitto interno mai risolto, in cui si è lanciata a piè pari, in cui l’Iran ha iniettato con astuzia giusto quel che bastava per impantanarla.
Washington, a sua volta, dovrebbe frenare l’Arabia Saudita per evitare ripetuti azzardi su ampia scala e magari riaprire il campo all’Isis e al-Qaeda, dopo gli sforzi per estirparli dall’Iraq e dalla Siria. Dietro la facciata della modernizzazione dello Stato, il delfino saudita ha, invero, concentrato sulla propria figura le leve del potere, assumendo la guida di Aramco – la maggiore compagnia petrolifera mondiale, e del comitato economico incaricato della sua privatizzazione, nonché il controllo diretto dei media del regno, e dei tre rami delle forze armate, da sempre distribuiti fra le diramazioni della famiglia reale, per mantenere un giusto bilanciamento tra i discendenti del fondatore del regno, Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud.
Ben lungi da qualsivoglia proponimento di laicità, si è manifestata, in parallelo, una precisa volontà di limitare l’autorità religiosa, che potrebbe arrivare a causare una rottura del patto sociale e di governo saudita, e un sovvertimento interno, alimentato dalle tensioni acuitesi all’interno della sovraffollata e impetuosa famiglia reale, le frange islamiche estremiste, e le classi popolari e impiegatizie, beneficiarie dei bonus redistributivi dell’industria estrattiva, in tempi di volatilità dei prezzi del greggio e imprevedibilità del futuro del mercato dell’energia.
Gli Stati Uniti hanno richiesto all’Arabia Saudita di diversificare l’economia, allentando la dipendenza dal petrolio, istituendo meccanismi decentrati di governo, e temperando il radicalismo religioso. La veste auspicabile per la superpotenza sarebbe quella di un accompagnamento tecnico attraverso un cammino di autentiche riforme e di energica dissuasione da tentazioni di destabilizzazione di una regione polarizzata. Tutto all’opposto, gli Stati Uniti sembrano metterci del proprio nell’alimentare il caos mediorientale.
L’annuncio del controverso riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele, in apparenza, riduce le prospettive del piano per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese, al quale la stessa amministrazione Trump sta lavorando da un anno. Ciò nondimeno, quello a cui gli americani, in questa tappa, sembrano puntare è l’abbandono della funzione di mediatori e la sua attribuzione all’Arabia Saudita. Il ragionamento, che parrebbe confermato dall’intesa menzionata in apertura dell’articolo, muove dal presupposto che la veemenza con cui è percepita la minaccia iraniana, colloca in secondo piano l’ostilità con Israele che condivide la visione del Golfo sull’Iran.
La scommessa dell’amministrazione Trump è sull’eventuale utilizzo di risorse economiche saudite per investimenti che garantiscano un futuro economico ai palestinesi e li persuadano a negoziare la pace in termini che gli israeliani siano in grado di accettare senza perdere la faccia. Il problema è che, a dispetto della qualità machiavellica delle speculazioni, i sauditi potrebbero non rivelarsi affidabili dal punto di vista diplomatico e gli israeliani ostinarsi nel non concedere le condizioni minime per la fondazione di uno Stato arabo limitrofo.
L’Arabia Saudita ha patteggiato con la Russia il taglio della produzione del petrolio e una tregua nella lotta di mercato, messa a repentaglio dall’aggressiva assunzione di quote da parte degli Stati Uniti, forti della propria competitività. Frattanto, la Palestina resta vulnerabile allo spettro dell’Intifada e le chiamate alla belligeranza di realtà come Turchia; e lo scontro per procura fra Arabia Saudita e Iran si intensifica senza soluzioni all’orizzonte, trascinandosi dietro un’intera regione e una scia di sangue.