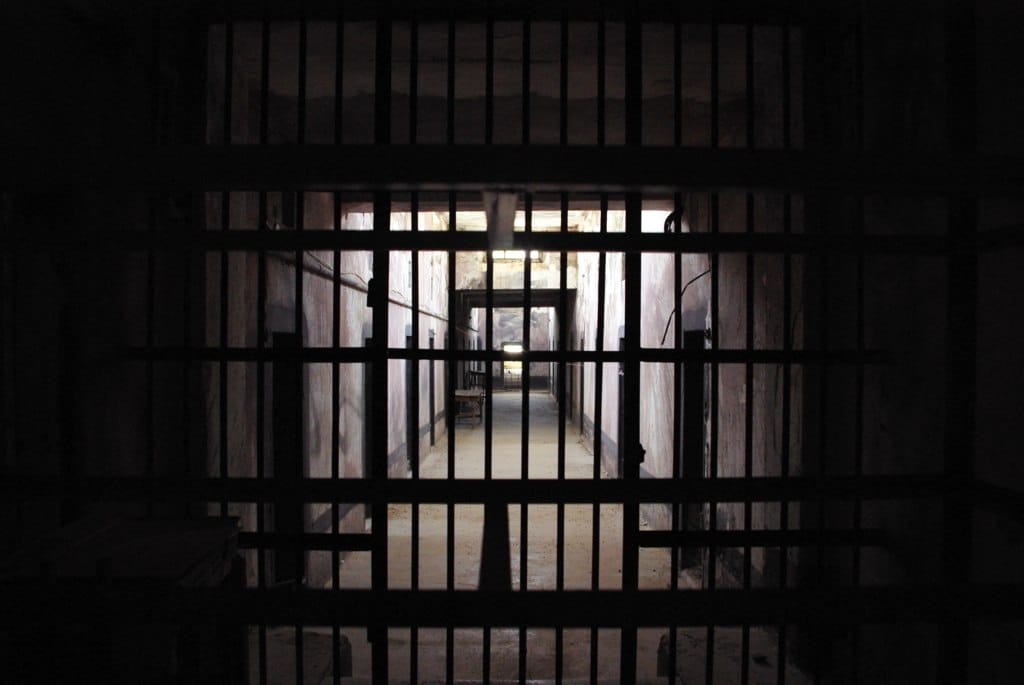Il carcere non è un luogo per trans.
È questa la prima considerazione che viene in mente guardando alle condizioni detentive delle persone transessuali e transgender in ogni parte del mondo.
Lo scarso riconoscimento di un’identità di genere diversa da quella binaria “tradizionale” porta infatti a discriminazioni, abusi verbali, psicologici e fisici nonché, in alcuni casi, a vere e proprie violenze sessuali.
Il Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite contro la tortura, già nel 2001, scriveva nel suo report: “abbiamo ricevuto informazioni secondo cui le persone transessuali e transgender, soprattutto donne, sarebbero a rischio elevato di abusi fisici e sessuali delle guardie carcerarie e degli altri detenuti”, in particolare “se collocate all’interno di strutture maschili”.
Dieci anni dopo, il Relatore Speciale sulla violenza contro le donne, raccontava di una detenuta trans in El Salvador “stuprata più di 100 volte dai membri di una gang all’interno di una prigione maschile con la complicità dei funzionari carcerari“.
Ancora nel 2016, il Comitato ONU contro la tortura, ribadiva che le persone transgender, alla stregua di altri gruppi vulnerabili, “sono a rischio di tortura e maltrattamenti se private della libertà”. A suo avviso, “le carenze strutturali proprie dei sistemi di giustizia penale hanno un impatto assai negativo sulle minoranze emarginate” tanto da richiedere “misure specifiche volte a proteggere e promuovere i loro diritti”.
In alcuni Paesi la situazione è di gran lunga più grave che in altri.
Il trattamento delle persone trans in stato detentivo, infatti, assume connotazioni differenti anche in ragione del modo in cui il transessualismo viene percepito e vissuto dal tessuto socio-culturale di appartenenza. I dati a disposizione, a livello globale, si focalizzano sulle donne trans (MtF). Mentre risultano pressoché inesistenti le informazioni relative agli uomini (FtM).
Mi hanno interrogata per ore picchiandomi senza tregua. Sono stata arrestata con la falsa accusa di sodomia. Per oltre 10 giorni mi hanno dato a malapena cibo e acqua, impedendomi di chiamare un avvocato. Mi hanno rasato i capelli. Mi hanno insultata usando anche l’appellativo ‘finocchio’ e sono stata costretta a subire molestie dalle forze dell’ordine e dagli altri detenuti
Randa è una giovane donna trans di origine siriana, arrestata in Libano nel 2017 senza aver commesso alcun crimine. Detenuta per 5 mesi e 5 giorni in una cella buia e rilasciata solo grazie all’intervento del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Non ha denunciato i soprusi subiti dalla polizia per paura di essere espulsa. La sua storia è riportata da Human Rights Watch nel report “Don’t Punish Me for Who I Am”.
Per molte società dell’Africa, Asia e Medio Oriente l’identità di genere si configura in via esclusiva nelle categorie maschio/femmina e nessun’altra opzione risulta concepibile.
Questa forma mentis spesso si riflette nelle loro leggi penali. Sebbene in nessuna legislazione sia contemplato il reato di transessualismo, molte normative contengono concetti vaghi e indefiniti – quali: “crimini contro l’ordine della natura“, “moralità“, “dissolutezza“, “grave scandalo” – che finiscono con il criminalizzare la persona transessuale in quanto tale.
L’organizzazione Human Dignity Trust, nel report 2019 “Injustice Exposed“, precisa che in 15 Stati sono vietate le “espressioni di genere” in contrasto con il proprio sesso biologico, cross-dressing incluso. Mentre 26 Stati usano i reati di ordine pubblico e vagabondaggio con il chiaro scopo di perseguitare le persone transgender. “[Queste] sono prese di mira soltanto perché non si conformano alle regole della società, della chiesa o della moschea”, dice Tea Braun, Direttrice di Human Dignity Trust, a Reuters.
Va da sé che se la persona trans è così tanto invisa alla collettività e alle istituzioni, il suo trattamento all’interno della struttura penitenziaria non sarà certo dei migliori. E la gamma delle violazioni dei diritti umani perpetrati in questi contesti diventa quindi amplissima.
Nel febbraio 2018, la polizia indonesiana ha fatto irruzione in 5 saloni di bellezza di Aceh arrestando 12 donne trans nell’ambito di un’operazione definita “programma per ripulire Aceh dalla transgender”.
Le vittime hanno raccontato ad Amnesty International di aver subito umiliazioni di ogni tipo mentre si trovavano in custodia. Sono state, tra l’altro, obbligate a simulare un addestramento militare indossando abiti maschili e a rasarsi i capelli per sembrare “più virili”. Prima di essere rilasciate, hanno dovuto ascoltare il sermone di un chierico musulmano che le ha invitate “a tornare alla loro vera natura” affermando che “è giusto uccidere le persone transgender (…) perché sono più malvage dell’infedele” tanto che “lo tsunami [del 2014] ha colpito la città proprio a causa dei loro peccati”.
Al netto di queste situazioni “estreme”, dove la transfobia è sponsorizzata in modo diretto dallo Stato e condivisa dalla società, va comunque evidenziato che in qualsivoglia istituzione carceraria del mondo manca la comprensione profonda di quelli che sono i bisogni specifici dei detenuti trans.
Ne deriva che il rischio di emarginazione così come di abuso è sempre dietro l’angolo.
Il National Center for Transgender Equality, ONG statunitense, segnala che negli USA “il 58% delle persone trans in stato di fermo, arresto o detenzione hanno subito, solo nel 2018, esperienze di molestie e maltrattamenti”. Molte di loro non hanno neppure denunciato “per paura di patire offese ulteriori nel corso delle indagini o di un processo”.
Va peraltro rilevato che, a partire da maggio 2018, negli Stati Uniti c’è stata una sorta di involuzione. Il Dipartimento di Giustizia ha infatti annullato le protezioni esistenti modificando le sue stesse linee guida del 2016. Queste consentivano di accogliere le persone transgender in istituti penitenziari federali corrispondenti al loro “sesso sentito”. Mentre adesso, il “sesso alla nascita” è tornato ad essere il criterio fondamentale per la determinazione iniziale del carcere. I prigionieri transgender vengono quindi assegnati a strutture conformi alla loro identità di genere solo “in rari casi“.
La questione cardine, da cui poi discendono una serie di altre difficoltà, attiene proprio alla collocazione di questi detenuti “speciali”.
Ovunque, i sistemi carcerari sono organizzati e gestiti sulla base di una rigida separazione in ragione del sesso biologico. Uomini e donne, nel rispetto degli standard internazionali, sono rinchiusi in istituti separati ovvero in sezioni distinte senza alcuna possibilità di contatto tra loro.
La detenuta trans, a meno che non abbia già subito l’intervento di riassegnazione del sesso e modificato i suoi documenti di identità, di solito viene affidata ad un carcere maschile (e viceversa). Nella migliore delle ipotesi sarà sistemata all’interno di un reparto riservato. In caso contrario, l’unica opzione, per motivi di ordine e sicurezza, sarà l’isolamento.
L’Unione Europea, a più riprese, ha chiesto agli Stati membri di “accogliere le persone in transizione all’interno di prigioni che corrispondano alla loro identità sessuale“. Purtroppo, questo metodo non viene quasi mai applicato da nessun Paese.
In Italia, nel silenzio della legge circa la collocazione dei detenuti trans, alcune carceri hanno messo in atto la prassi delle cosiddette “sezioni dedicate“. Si tratta, come precisa una circolare del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, di reparti destinati “al contenimento di soggetti che abbiano il divieto di incontro con la restante popolazione detenuta (…) per condizioni personali ovvero per ragioni detentive e/o processuali”.
Ad oggi, le “sezioni protette”, ospitando detenute trans, sono ubicate presso carceri maschili, con la sola eccezione della casa circondariale di Sollicciano.
Non tutte le strutture penitenziarie sono dotate di queste sezioni. Ma va comunque tenuto conto che le persone transgender rappresentano un’esigua minoranza della popolazione carceraria complessiva: 58 su circa 60.000 detenuti, secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Associazione Antigone.
Le “sezioni protette” sembrano rappresentare una discreta soluzione tra la necessità di tutelare le detenute trans e quella di garantire il normale svolgimento della vita carceraria. Certo, non è una scelta scevra da criticità.
Nell’ultima relazione del Garante dei Detenuti, si legge “[sarebbe] più congruo ospitare tali sezioni specifiche in Istituti femminili, dando maggior rilevanza al genere, in quanto vissuto soggettivo, piuttosto che alla contingente situazione anatomica”. Il Garante, inoltre, ha ribadito l’opportunità di sostenere “il principio dell’inclusività nella vita detentiva generale dell’Istituto” oltre a predisporre “sia attività specifiche, sia attività in comune con altre persone detenute”.
Posizione condivisa, come mostra una ricerca condotta nella sezione protetta di Ivrea, dalle stesse detenute trans che, da un lato, lamentano l’emarginazione dovuta proprio all’impossibilità di socializzare con gli altri detenuti nonché la scarsa offerta di programmi ricreativi e riabilitativi. Dall’altra, si dicono “contrarie alla proposta di istituire un carcere ad hoc per soli detenuti transgender, in quanto percepito come una forma di ulteriore ghettizzazione“.
In passato, nelle “sezioni dedicate” si sono registrati presunti episodi di violenza sessuale. Al momento, non si ha notizia di nuovi casi anche se le informazioni su quanto accade in carcere, di solito, arrivano molto lentamente all’esterno.
Non solo, Alessio Scandurra, Coordinatore dell’Osservatorio sulle condizioni di detenzione dell’Associazione Antigone, spiega a Voci Globali: “la preoccupazione è che si possano comunque verificare situazioni di illegalità sommersa a sfondo sessuale tra agenti di polizia penitenziaria e detenute trans“. Infatti, “in questi reparti, a differenza delle sezioni femminili – prosegue – gli agenti maschi hanno libero accesso per svolgere le loro funzioni”.
C’è quindi il rischio che “si creino relazioni basate sullo ‘scambio di favori’ ovvero sesso in cambio di piccoli oggetti materiali o trattamenti speciali” per alleviare il disagio legato al periodo detentivo. “Non è facile – conclude – far emergere questo tipo di realtà. È verosimile che si instauri un patto di omertà tra gli attori interessati”.
Va infine aggiunto che secondo l’OSCE, nel contesto europeo, si sta assistendo allo sviluppo di alcune “buone pratiche” attestanti una nascente sensibilità verso le esigenze di questa particolare categoria di detenuti. La stessa Italia è menzionata nel documento per i corsi offerti al personale penitenziario in tema di diritti umani e uguaglianza di genere delle persone LGBT.
Nel Regno Unito, invece, in base alle Prison Service Instruction n. 17/2016, l’istituzione carceraria è tenuta a chiedere ai transgender quale prigione meglio rispecchi il genere con cui si identificano. E qualora un detenuto trans desideri essere assegnato ad una struttura non conforme al suo “sesso legale”, una commissione interverrà a decidere caso per caso.
Mentre la Francia ha adottato, già dal 2010, una politica “gender-sensitive” in tema di perquisizioni personali. Queste devono avvenire sempre in condizioni di massimo rispetto per la dignità della persona trans. E nei casi in cui la riassegnazione del sesso è certificata, l’ispezione deve essere svolta da personale qualificato dello stesso sesso del riassegnato.
Ci sono poi un’infinita serie di altre questioni che meriterebbero approfondimento, tra cui l’accesso alle cure ormonali e al sostegno psicologico mirato, essendo la transizione una fase assai delicata della vita di una persona.
Il carcere di per sé non un luogo accogliente. Per le persone transessuali e transgender lo è ancora meno. Qualsiasi prigione infatti, pur rappresentando un microcosmo con codici di condotta propri non replicabili altrove, finisce sempre per rispecchiare la sottocultura dominante all’esterno. Nessuna società finché sarà intrisa di pregiudizi verso il “terzo genere” avrà istituzioni penitenziarie in grado di rispettare i diritti umani dei trans.