Rivoluzione digitale, diritti umani e globalizzazione
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vbFYudT9QWw[/youtube]
What’s going on? Già dieci anni fa, prima che comparisse l’iPhone, (vi ricordate? era il 2007), Giorgio Agamben dichiarò il suo “odio implacabile” per il telefonino, un dispositivo che aveva rimodellato da cima a fondo i comportamenti e anche i gesti degli individui, rendendo “ancora più astratti i rapporti tra le persone”: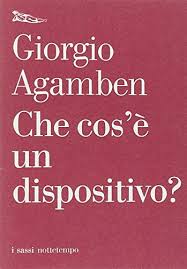
Malgrado mi sia sorpreso piú volte a pensare a come distruggere o disattivare i telefonini e a come eliminare o almeno punire e imprigionare coloro che ne fanno uso, non credo che sia questa la soluzione giusta del problema.
E infatti non è una soluzione. E forse, tutto sommato, neanche un problema. Tuttavia è più che mai importante prendere atto che ormai viviamo in un mondo integralmente digitalizzato. Ma siamo veramente in grado di capirlo e di gestirlo? Mi sembra sia questa la domanda che emerge, per un lettore comune e al di là dell’indubbio valore accademico, da The digital humanist: a critical inquiry, un libro scritto a sei mani (Domenico Fiormonte, Teresa Numerico, Francesca Tomasi) e pubblicato recentemente da punctum books, casa editrice newyorkese indipendente, para-accademica e open access. Il libro parte dalla constatazione che il fenomeno delle digital humanities (DH) è letteralmente esploso, arrivando anche sulle pagine di giornali come il New York Times, che nel 2010 ha inaugurato una sezione Humanities 2.0 sul sito. Si tratta di un campo di studi interdisciplinare che unisce informatica e scienze umane e che, con nomi diversi, covava sotto la cenere da tanto tempo. Negli ultimi 10 anni si è affermato sempre più, prima nelle Università anglosassoni e poi anche nel resto del mondo, non senza polemiche e resistenze di vario genere (per esempio si è parlato dell’esistenza di un dark side delle digital humanities – anche qui, a questo link e qui– o, più recentemente, di questioni di genere che affliggono questo nascente fenomeno). L’attuale disseminazione e diffusione globale, dimostrata per esempio da Around DH in 80 days, da Global Outlook o dalle numerose Associazioni che stanno nascendo dappertutto, ha reso neces sario, secondo gli autori, un esame critico dei principali concetti e pratiche delle DH. Non si tratta più solo del traghettamento in formato digitale dei diversi prodotti della cultura umana, che rimane comunque il compito principale, ma di prendere atto e prendere posizione di fronte a un fenomeno più ampio, ad un vero e proprio
sario, secondo gli autori, un esame critico dei principali concetti e pratiche delle DH. Non si tratta più solo del traghettamento in formato digitale dei diversi prodotti della cultura umana, che rimane comunque il compito principale, ma di prendere atto e prendere posizione di fronte a un fenomeno più ampio, ad un vero e proprio
cataclisma che sta cambiando non solo le scienze e la trasmissione del sapere, ma, come ben sappiamo, anche il mondo della finanza, della politica, del diritto, del commercio, delle relazioni umane in genere. La digitalizzazione già adesso non trasforma solo ciò che è al di fuori di noi, va ben oltre. Cambia anche la nostra “presenza digitale“, il controllo delle nostre identità, la rappresentazione del nostro pensiero, della nostra mente (con le neuro-immagini), anche il cibo che mangiamo, come dimostra la sempre più stretta relazione tra biotecnologie e la riduzione della biodiversità [Shiva 1993 e 2013].
Proprio per questo è importante parlare di questo libro per chi si occupa di diritti umani. Del resto gli stessi autori affermano che esiste un legame:
Il problema è più radicale. Per esempio, si può parlare oggi di diritti umani senza far riferimento a procedure e valori trasmessi attraverso prassi comunicative e flussi di documenti e di informazioni che dipendono da processi strettamente legati alle tecnologie informatiche? E si può parlare di questioni socio-politiche in Paesi come Egitto, Tunisia, Iran, o anche Stati Uniti o Cuba, senza prima capire com’è fatta e come funziona la loro infrastruttura di comunicazione, il loro network digitale?
Visto così, si tratta di un argomento che non può non interessare, e del resto su Voci Globali ci si è occupati di problemi digitali già in passato (pensate per esempio al pezzo sulla propaganda Isis o quello sugli attacchi alla libertà online. In realtà tutta la rubrica su Cultura e informazione digitale parla di questo). Uno dei temi più importanti è quello della globalizzazione. In particolare gli autori affrontano il problema della prevalenza dell’inglese all’interno delle comunità delle digital humanities, questione complessa e spinosa che influisce molto sul processo di globalizzazione (significativo sopratutto il fatto che il libro è appunto scritto in quella lingua – esiste in realtà una versione in italiano pubblicata nel 2010, ma ques’ultima edizione è, più che di una semplice traduzione, una riscrittura vera e propria).  Perchè, come sostiene Achille Mbembe, storico e filosofo della politica camerunense che vive e lavora a Johannesburg, per capire i processi di globalizzazione del nostro tempo occorre partire dalla consapevolezza che tutti i nostri discorsi sono necessariamente e inevitabilmente provinciali (indipendentemente dalla lingua che usiamo, aggiungerei):
Perchè, come sostiene Achille Mbembe, storico e filosofo della politica camerunense che vive e lavora a Johannesburg, per capire i processi di globalizzazione del nostro tempo occorre partire dalla consapevolezza che tutti i nostri discorsi sono necessariamente e inevitabilmente provinciali (indipendentemente dalla lingua che usiamo, aggiungerei):
Lo scopo del libro è contribuire […] alla critica di questo nostro tempo – il tempo […] della planetarizzazione del mondo. […] Un lavoro di questo tipo produce risultati solo se si apre ad una lettura a ritroso del nostro presente. Si parte dal presupposto che qualsiasi veritiera decostruzione del nostro mondo presente non può che cominciare dal pieno riconoscimento dello statuto forzatamente provinciale e dal carattere necessariamente regionale delle nostre idee – e dunque da una critica di qualunque astratto universalismo, in qualsiasi forma si presenti.
Si tratta di un’affermazione molto forte, ma si potrebbe andare anche oltre. Per esempio, Jean & John Comaroff, una coppia di antropologi, che insegnano all’Università di Chicago ma sono di origine sudafricana, in Theory From the South si pongono una domanda ancora più radicale:
E se affermassimo che, oggi come oggi, è il Sud del mondo, il global south, che riesce a proporre punti di vista originali su come funziona il mondo là fuori? Se dicessimo che è da qui che la nostra capacità di comprensione empirica delle sue caratteristiche principali e il lavoro teorico con cui riusciamo ad interpretarle e spiegarle, o perlomeno una parte molto importante di esse nasce e continuerà a nascere? O anche che, nel valutare la posta in gioco, possiamo andare
al di là dell’opposizione binaria tra Sud e Nord, e far venire fuori i processi dialettici più profondi e diffusi che l’hanno prodotta e la sorreggono?
Sembra che per capire il mondo attuale non bisogna più guardare ai teorici europei e occidentali, ma spostarsi a Sud, verso il cosiddetto global south. Perlomeno questa è l’ipotesi che gli autori vorrebbero testare, in maniera non dogmatica nè ideologica, sulla base della loro conoscenza della cultura africana. Ecco, volevo presentare un libro e ne ho presentati tre. The more the merrier (questo non lo traduco, se proprio volete ve lo fate tradurre da Google). Comunque tornando alle digital humanities, cosa ci stanno a fare in questo discorso? A mio avviso possono dare un contributo fondamentale sia alla comprensione dei processi di globalizzazione sia a un tentativo di promuovere punti di vista “provinciali” nel senso auspicato da Mbembe. Però è necessario che la politica sia al centro dell’attenzione, e infatti, come scrive nella prefazione Geoffrey Rockwell, professore canadese che da anni lavora nel settore delle digital humanities, gli autori del libro sostengono che “gli umanisti devono impegnarsi non solo a produrre contenuti digitali in Rete ma anche a riflettere e far riflettere su questioni etiche relative all’informatica, in particolare su questioni linguistiche, sui motori di ricerca, sull’open access e sulla censura“. Un’idea importante del libro è quella che dietro la rivoluzione informatica non ci sia una semplice innovazione tecnologica, ma il potere di una o più metafore, che hanno ispirato coloro che hanno concepito e creato le varie macchine calcolatrici. La storia del computer è in effetti, a ben guardare, ricca di visionari in cerca di macchine, come Turing, personaggio archetipico nella storia del digitale. Come si è visto in Imitation Game, egli, dopo aver concepito una macchina universale astratta, è riuscito a renderla concreta utilizzando le tecnologie di cui disponeva, e salvando le vite di molti soldati e civili nella Seconda guerra mondiale, en passant. Turing è una specie di nerd ante litteram, anche se nel suo caso il suo disadattamento non era dovuto all’intelligenza, ma ad altre cause, come sappiamo, il che rende la sua figura particolarmente eroica e tragica. Ma questa è un’altra storia. Tra le metafore che maggiormente hanno influito sulla storia del digitale, c’è quella dell’universalismo culturale, che si interseca con problemi come quelli della pace mondiale e del cosmopolitismo, con tutti i chiaroscuri che ho cercato di mettere in evidenza. Mi sembra che proprio in questa commistione stia uno dei nodi problematici del digitale, ossia nel modo in cui questa spinta universalizzante (che poi non è altro che un modo di intendere la globalizzazione) sia stata interpretata e incorporata nella creazione di macchine e strumenti digitali. Il libro propone molti spunti di riflessione che vanno in questa direzione. Tra i tanti che mi vengono in mente questi mi sembrano i più rilevanti:
- la discussione di come l’universalizing dream di Leibniz, l’idea cioè di creare un linguaggio universale che risolva i problemi di comunicazione tra gli uomini e le culture, un linguaggio che tutti possano capire e parlare, comprese le macchine, si è in qualche modo materializzato nei linguaggi dei computer (in fondo il termine stesso informatica si basa sull’idea di informazione automatica). Il semantic web in particolare, favorendo i processi di comunicazione globale, ha favorito in un certo senso l’universalismo astratto attaccato da Mbembe.
- l’analisi delle disuguaglianze nel web e di come il dominio dell’inglese si è trasferito anche nelle interfacce digitali (comprensibilmente, in parte, visto che lo sviluppo delle stesse è avvenuto principalmente in quel mondo e in quella cultura, ma non per questo meno preoccupante),
- il discorso su come le interfacce, oltre a essere scritte dagli utenti umani, li scrivono anche, in un certo senso, li costruiscono, oltre ad esserne costruite. Le identità digitali, il nostro modo di essere e di esprimerci attraverso il web, finisce con essere il prodotto di questi processi di astrazione globalizzante.
Certo, la visione di Mbembe è, o perlomeno sembra, molto pessimistica, ma non è detta l’ultima parola. Per questo il capitolo conclusivo di The Digital Humanist mi sembr estremamente importante, e direi anche incoraggiante, non solo quando dice che “la vera innovazione del prossimo decennio sembra essere l’espansione geografica”, ma anche per la constatazione che “la crescente presa di coscienza che il modo in cui si praticano le digital humanities nei diversi contesti culturali sta cambiando le gerarchie tradizionali tra il centro e la periferia”. Presentando svariate iniziative già esistenti, come per esempio Postcolonial DH, DH Commons, Digital Humanities Now, il libro riesce quindi a “introdurre i nuovi arrivati agli aspetti geo-culturali più complessi delle digital humanities”. E mi sembra un successo non da poco.
