Africa, giornalismo investigativo e media italiani
Giornalismo investigativo. Africa. Il pensiero, diciamo la verità, non va immediatamente alle firme del giornalismo africano. Quanti di noi per informarsi sull’Africa leggono report e inchieste sui media africani e – il numero qui va ancora a calare fino a diventare zero – quanti di noi leggono sui media italiani report e inchieste di giornalisti africani? E parliamo di questioni che riguardano il continente. Dove sarebbe più ovvio seguire e conoscere le storie raccontate dal field. Da giornalisti esperti per la conoscenza del loro territorio, degli aspetti sociali, politici ed economici (non ultimo culturali) del luogo da cui scrivono. Non da giornalisti del mordi e fuggi – o peggio quelli del desk – le cui storie spesso hanno lo stesso sapore di una minestra cotta e riscaldata chissà quante volte.
E se quindi ospitassimo firme africane sui nostri media, come già fanno – e da tempo – testate estere?

Qualche giorno fa tutte le agenzie di stampa italiane hanno scioperato contro il bando con cui il Governo italiano ha messo a gara aperta a chiunque in Europa i servizi di informazione di agenzia. Un collega ha commentato in un suo post: “Immagino sia chiaro a tutti che per fare informazione italiana magari essere slovacchi non aiuta“. Siamo d’accordo. Ma allora perché questo stesso principio non vale per l’Africa in cui l’Europa per dimensione sta dentro una decina di volte? Senza parlare della differente storia, cultura, ecc. ecc.?
No, non si tratta di svalutare il buon giornalismo di casa nostra che in qualche modo ha sdoganato l’Africa e l’ha portata all’attenzione del mondo. Ma il tempo delle corrispondenze estere è passato. Corrispondenze ormai limitate a pochi giornalisti europei, pochissimi soprattutto gli italiani. Il motivo? La solita mancanza di budget, ma sarebbe meglio dire, mancanza di visione. Errore madornale di valutazione.
Investimenti, approfondimenti, conoscenza, sostituiti dall’helicopter journalism. Quello di chi arriva, alloggia una o due settimane di solito in uno dei migliori alberghi di una capitale qualunque africana, e copre storie che meriterebbero mesi, a volte anni di studio per poter essere prima comprese, poi raccontate.
Per non parlare della tendenza dei freelance low budget a fiondarsi sul tema che in quel momento fa più scalpore e che hanno già coperto in tanti e tanti, fino a diventare solo un’espressione di narcisismo, autocompiacimento, autoreferenzialità.
Faccio un esempio, la grande discarica di Agbogbloshie ad Accra, nota anche come Sodoma e Gomorra, sta vivendo un periodo di sovraesposizione mediatica, con giornalisti e fotografi freelance che “vanno a vedere quali sono le condizioni di vita di questa povera gente” che ricicla il materiale elettronico che arriva da Stati Uniti ed Europa. Nessuno però, dico nessuno, che sia andato finora oltre l’aspetto di rammarico, di pietà, di denuncia, abbastanza generica, verso un Occidente, sfruttatore e vigliacco. Nessuno, dico nessuno, che abbia spiegato le dinamiche sociali, politiche e anche – perché no – l’aspetto edificante (sì, proprio così, ma dobbiamo rimandare l’argomento) di un luogo che sicuramente è una sorta di inferno sulla terra. Ma non rappresenta solo questo.
Ecco, per raccontare storie che superano il già detto, il già noto, il sensazionalismo, bisogna prima di tutto sapere di cosa si parla. E sapere non vuol dire aver letto qua e là o aver trascorso, facendo la parte degli eroi, qualche giorno nella discarica – tanto per restare su questo tema – scattando foto e ingraziandosi le persone che ci vivono con piccole somme di denaro. E questo è solo un esempio.
La prova di cosa? Che il giornalismo sull’Africa si riduce al solito riproporsi di luoghi comuni, opinioni più che fatti, racconti di pathos dalla lacrimuccia e/o l’indignazione facile. A questo riguardo aiuta molto la lettura critica e analitica di un breve saggio – sempre attuale – scritto a quattro mani da Evelyn Groenink e Anas Aremeyaw Anas, uno dei più noti giornalisti investigativi africani (che tra l’altro lo scorso anno Voci Globali ha portato al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia).
Direi che si tratta di una sintesi illuminante che dovrebbe essere letto da tutti quelli che scrivono d’Africa – o ne hanno la presunzione frequentandola a mala pena.
C’è un concetto riportato nell’analisi, quello di “do-gooderism”, vale a dire l’atteggiamento (e mentalità) dei buoni samaritani, dei benefattori. Concetto che crea veri e propri tabù nel modo di trattare storie dall’Africa.
Ovviamente ne è affetto l’Occidente, compresa la stampa. Un atteggiamento mentale che travisa l’esperienza in Africa e il modo di raccontarla, anche se a raccontare sono dei professionisti. È quell’atteggiamento che scrive del traffico internazionale di prostitute sempre come vittime sfruttate e raggirate, senza mai interrogarsi sulla “scelta” di trasferirsi all’estero consapevolmente (e come sex-workers) per guadagnare meglio. È quell’atteggiamento mentale che quando racconta della tragedia dei gorilla decimati del Virunga mostra locali buoni e sottomessi e altrettanto selvaggi, senza soffermarsi sulla loro rabbia o sui movimenti civili a protezione dell’ambiente. O, ancora, quell’atteggiamento, che non consente di guardare a fondo cosa veramene significa il fair trade, commercio equo e solidale che tanto piace a certi consumatori occidentali, per le popolazioni locali. E perché non si racconta davvero cosa succede con milioni di zanzariere spedite dalle ONG (o portate in Africa da bravi volontari) mentre non si risolve il problema della malaria alla radice. O si continua ad insistere sulle mutilazioni genitali femminili senza invece riportare l’alta percentuale di cambiamento di questa pratica. A chi giova tenere in piedi certi modi pensare e conoscere l’Africa? Attenzione, qui non si negano certe tematiche, se ne contesta l’uso strumentale.
La questione poi è anche questa: quanta libertà hanno i giornalisti occidentali e, soprattutto, italiani? A quante e quali ONG devono rispondere quando vanno per un servizio in un Paese africano dove da queste organizzazioni ricevono notizie (ovviamente legate alle attività delle stesse ONG), appoggio e contatti? Quanto devono rispondere al mondo politico della cooperazione internazionale? E quanto, last but not least, ai preconcetti e ai tabù sul continente?
Il problema principale per una certa parte di giornalisti, videomaker e fotografi, è che partono avendo già in mente ciò che scriveranno. O filmeranno o fotograferanno. Questo preconcetto impedisce di guardare davvero quello che è intorno e che, forse, potrebbe cambiare, il punto di vista o l’angolo di visuale messo a fuoco.
Stiamo parlando di quelli che intraprendono un viaggio, ma più spesso – soprattutto per i media italiani – i pezzi sono scritti a tavolino, raffazzonando qua e là notizie di agenzia o altri articoli che a loro volta ripropongono la solita frittata.
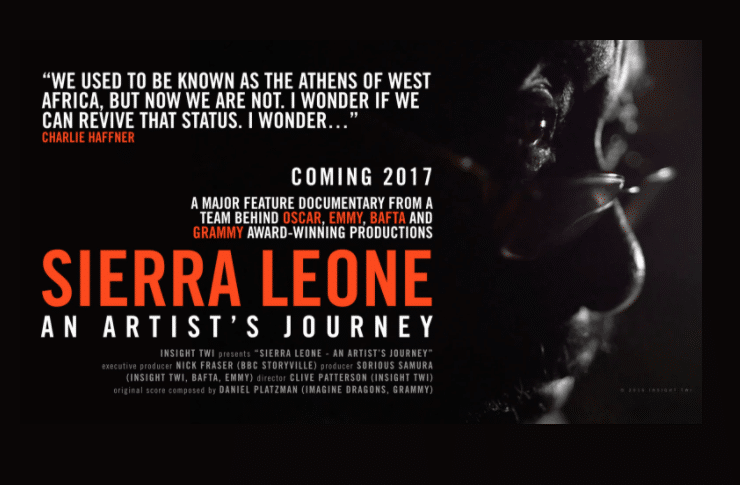
Quanto sarebbe interessante invece (e serio) conoscere e valutare il giornalismo investigativo africano. In generale i giornalisti africani e il loro lavoro. E a dargli spazio, magari, perché come spesso ha ricordato Idris Akinbajo, giornalista nigeriano dai numerosi riconoscimenti internazionali: “le nostre storie hanno molto più impatto quando assumono un respiro internazionale perché sono pubblicati da media occidentali. Solo in quel caso i nostri leader ci ascoltano”. Che paradosso.
Ed è questo un altro dramma. Ci sono giornalisti africani che hanno rischiato e rischiano la vita per portare alla luce storie complesse (non semplificate come quelle che spesso appaiono sui nostri media) di corruzione, scandali, abusi di potere. Lo fanno nei loro Paesi, ma rimangono sconosciuti a gran parte non sono dei lettori occidentali, ma degli stessi giornalisti che poi si recano nei loro Paesi con la pretesa di spiegare. In questa sintesi, ferma agli anni 2000, ne abbiamo qualche esempio. E ai leader, alla fin fine, importa poco quello che scrivono, perché se non arrivano sui media grossi, quelli che contano, quelli dell’Ovest del mondo, allora possono continuare a stare tranquilli.
L’Africa però, per dirla in breve, non ha bisogno che altri la raccontino. Le forze in campo qui sono molte. E sono loro che dovrebbero darci informazioni di prima mano. Poi va bene, partire, osservare, raccontare. Magari lasciando a casa la tracotanza del “so tutto”.
Di giornalisti impegnati, in Africa ce ne sono una miriade, basti guardare – per esempio – al programma dello scorso anno e ai suoi speaker del The African Investigative Journalism Conference, organizzato dallUniversità di giornalismo di Johannesburg. Mentre si attende l’evento di quest’anno, a novembre che, guarda caso, sarà tenuto su territorio africano per la prima volta.
Insomma, basterebbe smetterla di pensare in modo eurocentrico per scoprire il mondo e imparare a raccontarlo meglio. Per noi giornalisti è un dovere, non un’opzione.
[Di questo – e di altro – parleremo con i nostri ospiti nei due appuntamenti in programma quest’anno al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia. Il 6 aprile e il 7 aprile].
