Operazione Cóndor, dall’Italia la speranza di giustizia
[Aggiornamento: qui per l’esito della sentenza]. Il 17 gennaio prossimo si pronuncerà la sentenza nel processo italiano per i crimini dell’Operazione Cóndor (Plan Cóndor), conclusione di un lungo percorso che ha avuto inizio nel 1998 con le indagini preliminari e che è proseguito dal 2013 nell’aula bunker di Rebibbia a Roma in forma di processo pubblico.
In quell’aula hanno deposto centinaia di persone, in primo luogo i familiari di alcune delle 23 vittime di origine italiana scomparse fra gli anni ’70 e il finire degli anni ’80, nei territori in cui hanno avuto luogo le dittature latinoamericane. Il reato è quello di lesa umanità per il crimine di omicidio aggravato, conseguente a desaparición forzata, operazione che un vasto gruppo di militari e non solo, portò a termine sistematicamente.
Il piano di morte inizia nel 1975 quando Augusto Pinochet convoca e sigilla il patto di collaborazione per combattere le opposizioni politiche insieme a rappresentanti di Brasile, Uruguay, Argentina, Paraguay e Bolivia. In coordinamento informativo con gli Stati Uniti e l’agenzia di intelligence CIA.
Le testimonianze hanno tentato di ricostruire le circostanze dei singoli casi. Familiari, superstiti, ex compagni dei desaparecidos, rappresentanti politici (come la figlia di Allende) ed esperti della materia hanno contribuito alla ricostruzione narrativa ed emotiva dei fatti.
Sono passati circa quarant’anni ma alcuni dei testimoni parlano in pubblico per la prima volta e hanno l’opportunità di esporre ad altri la loro verità e le parole portate con sé in anni di dolore e sospensione.
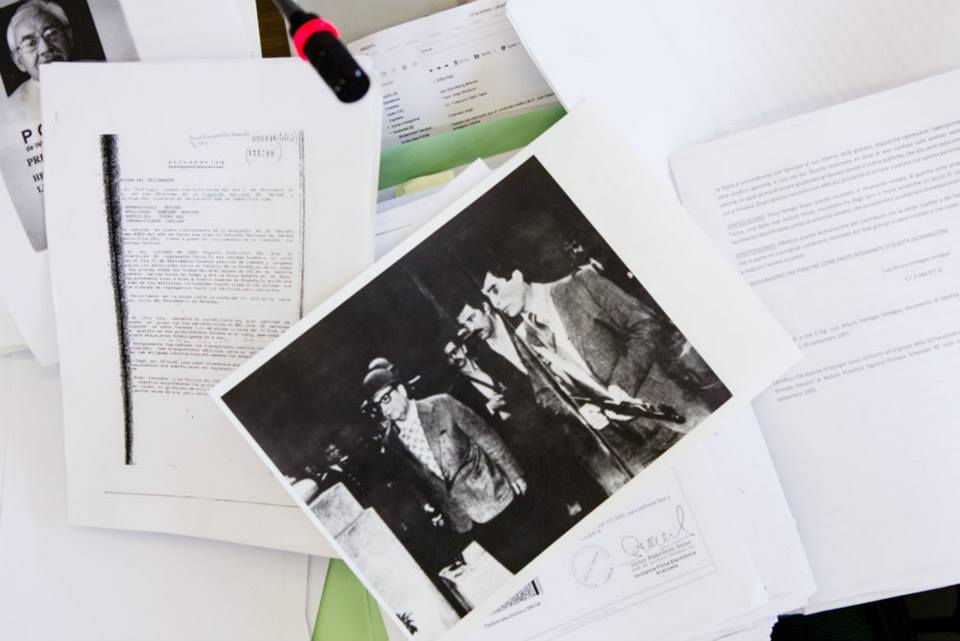
Nel corso dei processi, non solo in Italia, ci si è dovuti confrontare con leggi di immunità o di amnistia. In Cile si è verificato di recente che i familiari sono stati sottoposti alla pressione di dover vagliare le richieste di perdono pubblico da parte di alcuni assassini già condannati, pronunciate in cambio di benefici carcerari. Tutto ciò malgrado il ritrovamento di archivi documentali e fotografici inediti – come quello ritrovato da Martín Almada in Paraguay – che narrano degli orrori compiuti.
Uno dei due imputati comparsi in tribunale per ribadire la sua innocenza è Jorge Troccoli Fernández, cittadino uruguaiano residente da anni in Italia, e tuttora impunito grazie alla sua fuga dall’Uruguay e nonostante i plurimi capi d’imputazione. Molti imputati nel frattempo sono morti, altri scontano le pene in carceri speciali, altri ancora sono giudicati per la prima volta.
Il processo italiano, inoltre, è stato il primo a mettere in luce le operazioni criminali che ebbero luogo il giorno dell’assalto della Moneda in Cile, recuperando significativamente un frammento storico cruciale, impresso a fuoco nella memoria di tanti cittadini cileni che però, allo stesso tempo, si è lasciato intatto per quanto riguarda i nomi dei responsabili delle uccisioni di alcuni militanti del gruppo di difesa del presidente Allende.
Non si può parlare di elaborazione del lutto senza giustizia, serve la determinazione delle istituzioni per conoscere finalmente il destino degli scomparsi.
Andrea Speranzoni è uno degli avvocati dell’equipe italiana della difesa. L’avvocato – che fra l’altro si è occupato per molti anni dei delitti nazifascisti commessi in Italia e di terrorismo di Stato – ha il mandato di otto familiari delle vittime di origine italiana, all’epoca cittadini dei Paesi implicati.
Qual è l’importanza storica specifica che ha avuto svolgere il processo in Italia?
Quella di ribadire una volta di più la natura criminale dei regimi latinoamericani che hanno impedito lo sviluppo di esperimenti e percorsi democratici in America Latina fra gli anni ’70 e la fine degli anni ’80. L’eredità di quella esperienza criminale pesa ancora oggi nella vita negli uomini e nelle donne dei Paesi latinoamericani. L’importanza è poi anche giudiziaria ma c’è una importanza storica, nell’accezione di storia giudiziaria, che in questo processo dimostra ai criminali di ieri e di oggi che ottenere giustizia è possibile, anche se tardi.
Il Plan Cóndor è stata un’operazione plurinazionale, quali sono stati gli ostacoli materiali affrontati nel portare a termine le indagini?
Le difficoltà sono state tante e diverse fra loro. Una è stata quella di entrare nelle dinamiche storiche di quella stagione criminale in un’altra parte del mondo, l’America Latina appunto. Una seconda difficoltà, non piccola, è stata quella linguistica, per entrare nel profondo della lettura degli atti in lingua spagnola, atti giudiziari, atti di polizia, documenti dei servizi segreti dei vari Paesi coinvolti. Un ulteriore elemento di complessità, più legato al funzionamento della macchina repressiva, è stato quello di analizzare e capire durante il processo come si strutturavano i rapporti fra servizi di intelligence militari dei vari Paesi in operazioni congiunte che hanno portato al sequestro e all’omicidio di decine di cittadini italo-cileni, italo-argentini e italo-uruguaiani. Uso il caso cileno come esempio: capire come era strutturata la Direzione di Intelligence Nazionale (DINA) fra il 1975 e il 1976, come si organizzavano le operazioni da svolgere contro cileni residenti in altri Paesi dell’America Latina. Allo stesso modo, abbiamo dovuto capire come in Uruguay funzionavano organismi come l’OCOA o il FUSNA, lì dove operavano congiuntamente con i servizi di polizia argentini nel ’77 e nel ’78 e, quindi, abbiamo dovuto cercare di capire quali erano i collegamenti, quali erano le sinapsi e l’aspetto organizzativo di un’operazione in cui i servizi di intelligence militare e le organizzazioni militari repressive di ciascun Paese si avvalevano dell’aiuto di altri criminali di Stato in altri Paesi. Penso al Brasile, alla Bolivia, al Perù, penso ovviamente all’Argentina dopo il golpe di Videla e all’Uruguay dopo il golpe di Bordaberry.
Alla luce di queste indagini attraverso cui siete riusciti a spiegare il funzionamento della macchina della morte, qual è il profilo dei responsabili dei crimini?
Il profilo dei responsabili non è di un solo tipo. Il paradigma comune è l’agire criminale, senza dubbio, questo è l’unico comune denominatore che mette assieme tutti i responsabili. Ci sono poi responsabili operativi e responsabili organizzativi. Il profilo dei vertici, cioè, di coloro che avevano funzioni organizzative in primo luogo, è un profilo di specializzazione nel dirigere e articolare strutture militari in funzione della cosiddetta guerra politica interna ed esterna e nell’attività di gestione. Queste persone avevano indubbiamente una capacità organizzativa di carattere criminale di primo livello. Non è diverso vedere come, per esempio, è stato organizzato il Reparto Operazioni della DINA cilena da come sono stati organizzati negli anni ’30-’40, sotto il regime nazista, i sistemi della deportazione, i sistemi dei campi di sterminio. Cambia la dimensione, cambia il numero di vittime, non cambia il grigio e asettico modo di gestire questa macchina da un punto di vista organizzativo e amministrativo. Il cervello dell’organizzazione, inoltre, un altro profilo dei vertici, presenta un forte odio ideologico nei confronti delle persone da eliminare. La guerra politica implicava anche questa nozione di nemico assoluto che comportava una visione degli esseri umani completamente spossessati dalla loro umanità e concepiti come oggetti. È questa una concezione criminale di gravissimo e altissimo livello che porta, anche nei casi di organizzazione dei centri di detenzione clandestini, dove si praticavano tortura e omicidi, a un tale livello di crudeltà da trasformarsi in indifferenza.

E il profilo delle vittime?
Le vittime sono qualificate nel nostro processo da un vincolo di appartenenza. Sono vittime del partito socialista cileno, del partito Comunista cileno, del Mapu, della guardia degli Amici del Presidente Allende (GAP); guardando all’Uruguay sono ex appartenenti al GAU, al Partido por la Victoria del Pueblo, ai montoneros; guardando all’Argentina abbiamo membri delle Gioventù comunista argentina, lo stesso dicasi per la Gioventù comunista uruguaiana. Si tratta di vittime politiche, appartenenti a gruppi politici che all’epoca svolgevano attività contro la dittatura e che avevano una funzione nella dialettica democratica e anche talvolta nella dialettica rivoluzionaria prima della dittatura, nel portare avanti un discorso di giustizia sociale o di radicale cambiamento dei rapporti di forza economici nelle società latinoamericane.
Cosa si aspettano i familiari da questo processo?
Si aspettano di sapere, di avere informazioni su quello che è il punto centrale per ognuno di loro nei casi di desaparecidos, i casi cioè in cui i corpi dei loro congiunti non sono stati ritrovati. Sperano di ottenere in questo processo informazioni utili a individuare i corpi dei loro congiunti o a sapere, quanto meno, dove sono, anche se non sono più ritrovabili, dove sono stati sepolti o inabissati nel caso dei voli della morte sull’oceano. Ovviamente si aspettano anche di avere giustizia, che in concreto vuol dire avere una sentenza che descriva la sorte dei loro congiunti, descriva la responsabilità di coloro che hanno avuto un ruolo nel commettere questi crimini, e si aspettano anche una risposta da parte dei loro Paesi. E qui c’è una grande contraddizione emersa nel corso di questo processo, una contraddizione che abbiamo avuto anche in Italia dopo la caduta del fascismo, quindi c’è una costante in questi fenomeni, ovvero la scarsa, relativa nei casi migliori, capacità della politica e del diritto nelle fasi di transizione di garantire giustizia a chi ha subito crimini di lesa umanità.
Come contribuisce questo processo al diritto internazionale?
Questo è un aspetto molto importante perché contribuisce a una giustizia sovranazionale, a dare risposte sovranazionali a problemi nazionali utilizzando dei criteri interni, in questo caso alla giurisdizione italiana, ma questo vale anche per altre giurisdizioni e altre esperienze simili in Europa a crimini che non hanno un limite nei confini nazionali per essere giudicati. La nazionalità della vittima, nel caso italiano, attrae la competenza davanti al giudice italiano e quindi abbiamo una declinazione di una giustizia sovranazionale che opera attraverso la giuridisdizione universale o attraverso il principio di competenza giurisdizionale legata alla nazionalità della vittima o, nel caso anche delle sentenze interne dei Paesi latinoamericani, legate alla finalità di punire i crimini di lesa umanità. L’insieme di queste esperienze interne ed estere suggerisce un panorama di giustizia che va oltre i confini nazionali e che può in qualche modo cooperare tra un Paese e l’altro per punire i crimini di lesa umanità o anche, in passato, i crimini di guerra.
Una cosa che si sottolinea pochissimo è che il diritto non è un monolite, il diritto è qualcosa che cammina, la giustizia è qualcosa che cambia, i principi di diritto cambiano con l’evoluzione del pensiero, della società, così come gli orientamenti giurisprudenziali delle decisioni dei giudici. Quindi il lavoro e lo sforzo che con questo processo è stato portato avanti, assieme a tutte le altre esperienze di giustizia in America Latina, ecco, tutto questo io mi auguro possa concorrere a creare una coscienza giuridica e poi, di riflesso, civile su questi crimini che permetta non solo di prevenirli per il futuro ma anche di rileggere i contesti storico-sociali in cui hanno trovato spazio.
Sul piano personale qual è il caso che l’ha colpito di più o quello che ritiene più emblematico?
Ogni caso in qualche modo mi ha colpito. Sicuramente mi vengono in mente tre casi che hanno segnato in modo particolare il mio percorso. Il caso della desaparecida Maria Asunción Artigas, una ragazza uruguaiana che viene sequestrata nel 1977 e finisce in un centro di detenzione clandestino insieme al marito in Argentina. Questa ragazza era al terzo mese di gravidanza e verrà fatta partorire in regime detentivo alcuni mesi dopo. Alcune delle persone che erano con lei hanno descritto il parto di questa persona con mani legate e con un cappuccio in testa, questa è un’immagine che resta perché è l’immagine di una donna che dona una vita e a cui la vita viene negata. La bambina poi è stata testimone nell’aula giudiziaria di Roma e quindi è stata una di quelle nipoti ritrovate grazie al lavoro delle Abuelas de Plaza de Mayo argentine, grazie a questo sforzo abbiamo potuto sentire da lei la storia della sua vita. Rimane questa immagine di una vita che nasce e viene, appunto, sottratta e impedita, nella madre e nella figlia.
Un’altra immagine è quella di Juan Montiglio Murua, l’uomo che era a fianco del presidente Allende durante l’attacco alla Moneda, ecco, di questo caso resta impressa la parola di un testimone nel processo che ci ha ricordato di come in una situazione in cui era materialmente impossibile difendere il presidente, quest’uomo si diede da fare incoraggiando le persone intrappolate nel Palazzo della Moneda, anche durante il bombardamento, e salvò sicuramente molti suoi compagni, distruggendo l’archivio dei GAP custodito alla Moneda.
 Un’altra immagine emblematica è quella della sorella di Juan Maino Canales, un altro desaparecido cileno, che, in modo spontaneo, in un momento particolare del processo, in cui raccontava il sequestro del fratello avvenuto a Santiago nel maggio del 1976, tirò fuori da una tasca l’orologio appartenuto a lui mostrandolo alla Corte dicendo che per sentire la vicinanza del fratello l’unico modo che aveva era quello di sentire il cuoio del cinturino dell’orologio, pensando che aveva toccato la pelle del fratello.
Un’altra immagine emblematica è quella della sorella di Juan Maino Canales, un altro desaparecido cileno, che, in modo spontaneo, in un momento particolare del processo, in cui raccontava il sequestro del fratello avvenuto a Santiago nel maggio del 1976, tirò fuori da una tasca l’orologio appartenuto a lui mostrandolo alla Corte dicendo che per sentire la vicinanza del fratello l’unico modo che aveva era quello di sentire il cuoio del cinturino dell’orologio, pensando che aveva toccato la pelle del fratello.
Dietro a questa immagine dell’orologio io vedo l’immagine di un tempo fermato, di un tempo sottratto a queste persone che forse la giustizia o quest’opera di ricostruzione faticosa che stiamo facendo per avere altri pezzi di verità sulla loro sorte, può rimettere in movimento. La Corte Suprema argentina ha parlato di desaparición come crimine di tortura permanente. I familiari dei desaparecidos vengono sottoposti a questa tortura, appunto, legata alla sparizione che non consente l’elaborazione di un lutto e questa situazione in qualche modo ferma il tempo interiore, non il tempo dell’orologio, ma il tempo che è dentro ognuno di noi e che permette di elaborare le esperienze tragiche che ci capitano. Nel caso dei desaparecidos il tempo è stato interrotto dai criminali e la giustizia con modestia e con relatività può rimettere in moto le lancette di questo tempo interiore.


